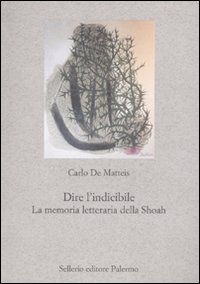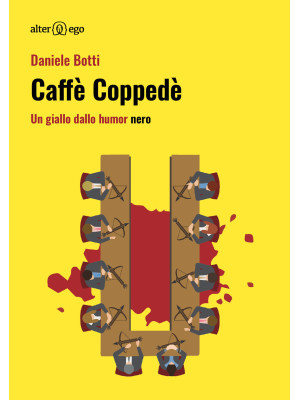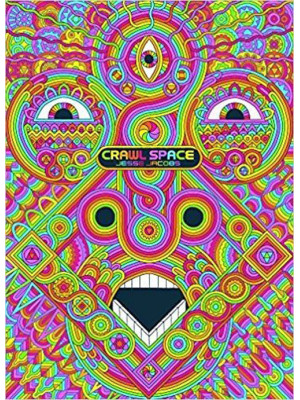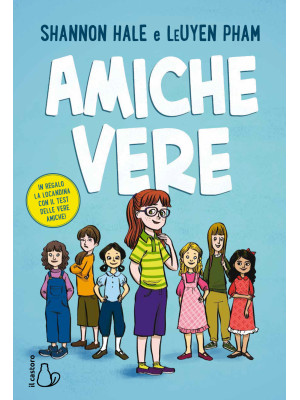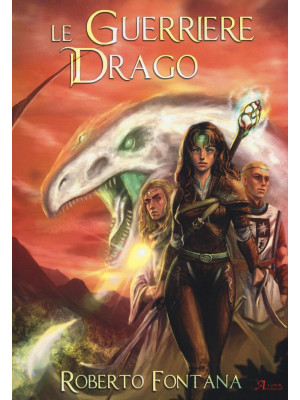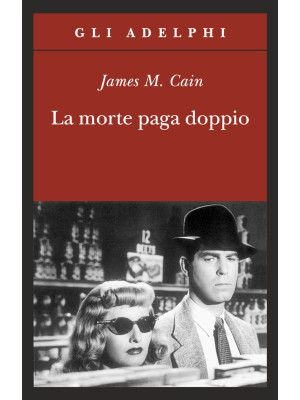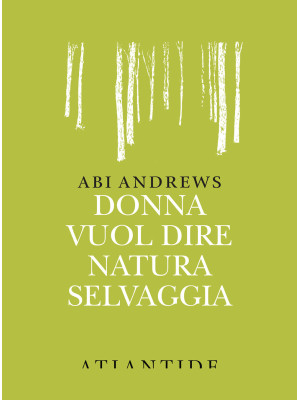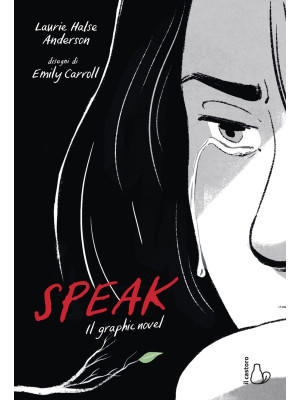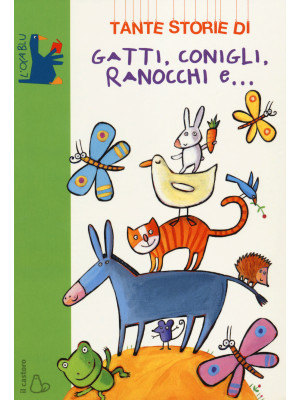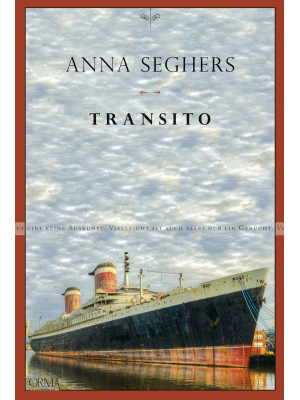Tab Article
"Sarà mai concepibile una lingua propria ed esclusiva dell'Olocausto? E se sì, allora questa lingua non dovrebbe essere talmente terribile e talmente funebre da distruggere, alla fine, tutti quelli che la parlano?" si chiedeva Imre Kertész. Come tutti gli altri reduci dei campi dedicatisi alla memoria letteraria della Shoah, il rovello del grande ungherese autore di "Essere senza domani", era quello di come rendere la parola a ciò che non può essere detto, a ciò che non conosce una lingua adeguata per esprimerlo: o che, se la trova, rischia a ogni momento lo scacco delle parole di fronte all'immane indicibilità di ciò che raccontano. E il rovello, il paradosso di dire l'indicibile, patito da ogni sopravvissuto, da Primo Levi a Jean Améry e a tutti gli altri che vollero raccontare. A questo è dedicato il presente saggio che per la prima volta si rivolge alla narrazione dell'esperienza dei lager come genere, analizzando le modalità di costruzione letteraria della memoria concentrazionaria: dai già citati Kertész, Levi e Améry, fino alle voci di donne di Auschwitz, le Bruck, le Delbo, le Berger, alla notte di Wiesel, al "nichilismo" di Borowski, fino alle riflessioni religiose, cattoliche e ebraiche di fronte al male, allo scavo psicoanalitico di Bettelheim e, infine, alla poesia di Celan. Lo studio concerne quindi non le comuni testimonianze dei deportati ma quelle di coloro che diverranno poi professionalmente scrittori, la cui opera cioè assume uno specifico valore letterario.