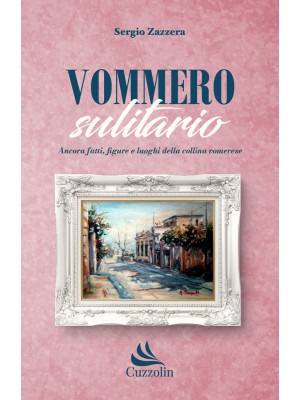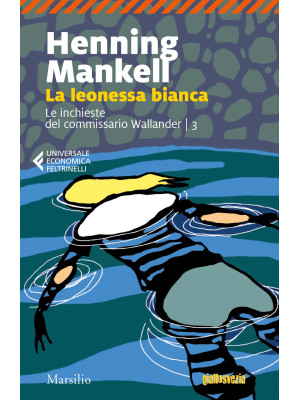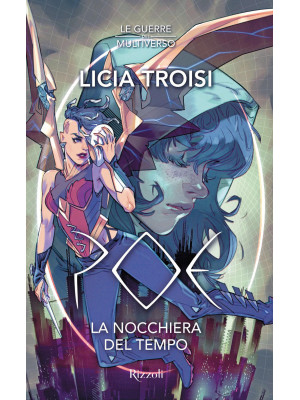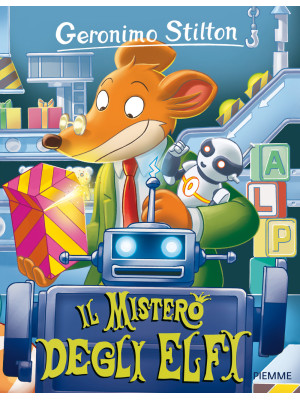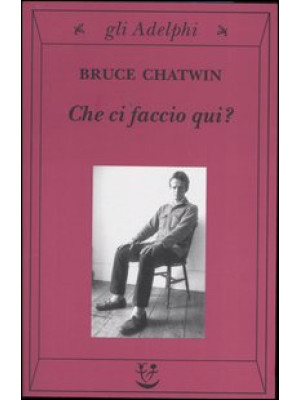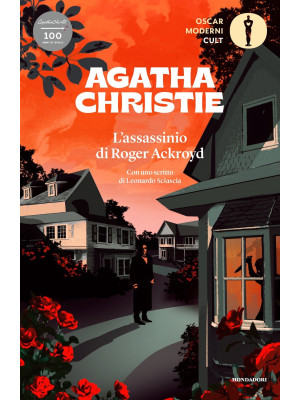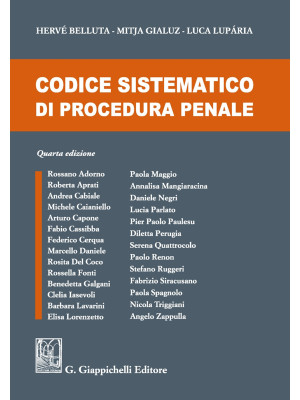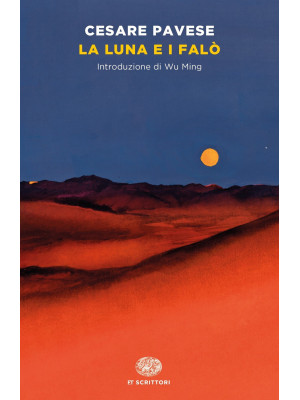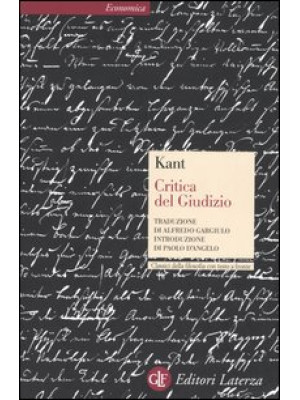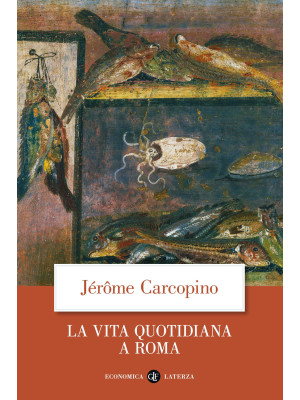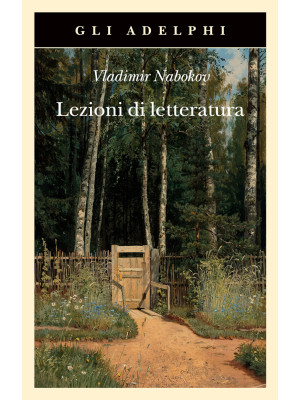Tab Article
È poesia - quella di Garufi - che scaturisce dallo strappo e dal dolore, e che non rinuncia a quel dolore universale su cui s'interroga e a cui cerca di dare risposta, che è poi la risposta stessa della ragione di scrivere: "Ma tu, esiliato scriba, a chi dedichi/ il tuo canto e perché?/ È la domanda onnipresente/ che mi faccio e che rivolgo/ alla pagina alla sua frontiera/ contro lo scorrere dei corpi martoriati/ delle case senza voci dei soffocati/ gemiti e guardo e scrivo/ di quelle mani tese, così in alto.../ (e il mio cruccio è il vero pianto)". Dove - al di là dell'indignazione che pure si affaccia, e che rende meno aggiuntive le crudeli, secche e icastiche Poesie del disamore - c'è da notare almeno la condizione d'esilio in cui il poeta si colloca, insieme con l'abbraccio comunitario (la comune ferita), il fondativo interrogarsi e interrogare, l'iconica raffigurazione (vagamente espressionistica) delle "mani tese" in quell'alzata sospensiva (le frequenti aposiopesi di Garufi sono gli indizi di una umanissima ma non crepuscolare, se non in senso non banalizzabile, "perplessità"), e infine il notevole enjambement "soffocati/gemiti" a incidere, se si può dirla così, un ossimoro voltato in visione: e persino in religiosa visione.